|

|
La
storia dell'Alfetta GT - GTV cominciò quando era all'apice il
successo della Giulia GT. Eravamo nel 1967, anno in cui venne
lanciata la 1750 GT Veloce e proprio sulla meccanica di questo
modello i vertici della Casa avevano l'intenzione di impostare la
coupé Alfa Romeo per gli anni Settanta. Il progetto venne
effettivamente varato nel 1968 e il compito di studiare le linee
della nuova carrozzeria fu affidato direttamente a Giorgetto
Giugiato, che aveva appena fondato la Italdesign. Alla fine degli
anni Sessanta, non sfuggiva a nessuno il fatto che il concetto
tradizionale di coupé, inteso come vettura sportiva bassa e con un
abitacolo capace di accogliere comodamente solo due persone, fosse
ormai superato. Le brillanti berline compatte, con pari prestazioni
ma con abitabilità, comfort e capacità del vano bagagli ben
superiori, stavano velocemente conquistando gli automobilisti più
sportivi. Giugiaro quindi ricevette un'istruzione precisa: la nuova
coupé Alfa, per dimostrarsi appetibile, avrebbe dovuto avere
quattro posti comodi e un capiente bagagliaio; per il resto venne
data carta bianca. Le dimensioni "importanti"
dell'abitacolo vincolarono fortemente la definizione stilistica che,
a questo punto, per scelta dello stilista torinese, andò oltre i
canoni tradizionali. Prendendo come riferimento la Giulia GT egli ne
mantenne il passo, ma "gonfiò" al massimo il padiglione
spostando all'indietro l'equilibrio dei volumi. Nell'immagine che
segue, un confronto tra i profili della Giulia GT e dell'Alfetta GT.
|
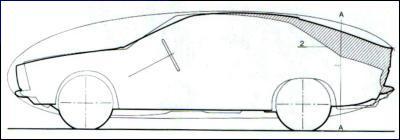
|
La
forte inclinazione del parabrezza e l'accenno di spoiler sulla coda
tronca servivano a dare all'insieme più slancio e dinamismo. Sin
dai primi schizzi, la nuova GT apparve molto vicina a quella che
sarebbe poi stata nella sua forma definitiva. Particolari come i
fari a scomparsa o le porte allungate verso la coda vennero presto
rimpiazzati da soluzioni più convenzionali; ma uno di essi rimase
su tutte le proposte grafiche di Giugiaro e su tutti i prototipi da
lui realizzati: il cofano motore che sormontava la cornice inferiore
del parabrezza e formava una carenatura per i tergicristallo. Un
dettaglio a cui Giugiaro teneva molto e che però sarebbe stato
seccamente bocciato dai tecnici Alfa Romeo che non ne compresero né
la modernità estetica né la funzione aerodinamica. Tuttavia, nella
sua globalità, il progetto Italdesign venne senz'altro preferito a
quello sviluppato parallelamente ad Arese, che fu abbandonato alla
fine del 1969. A questo punto, Giugiaro aveva esaurito il suo
compito e il lavoro passò in mano all'Alfa Romeo. Una serie di
cause, fece sì che la nuova coupé Alfa vedesse la luce quasi
cinque anni dopo. La principale fu sicuramente il progetto di una
nuova meccanica, che sarebbe andata ad equipaggiare la futura
Alfetta berlina. Ad Arese si decise che la nuova coupé doveva
essere una Alfetta GT, quindi con una impostazione meccanica
strettamente derivata da quella della nuova berlina. Il progetto
della scocca, uno dei primi sviluppati al computer, venne quindi
rivisto in funzione di questo fatto. Nel frattempo, gli stilisti
apportarono alcune modifiche alla carrozzeria rispetto al disegno di
Giugiaro; sul primo prototipo della Casa, pronto nell'aprile 1970,
il parabrezza era meno inclinato e il cofano motore non sormontava
più il parabrezza. Nel gennaio 1971 vennero definiti gli interni e
nel luglio dello stesso anno apparve il prototipo definitivo;
dopodiché iniziò la lunga messa a punto della vettura. Le prove in
galleria del vento evidenziarono un Cx di 0,391: un valore tutto
sommato elevato, dovuto soprattutto ai particolari sporgenti
dell'abbigliamento e alla forma poco omogenea del muso. Le prove su
strada portarono all'aggiunta dei due semi-spoiler frontali
(adottati per contrastare la portanza del muso in velocità) e alla
taratura ottimale delle sospensioni. L'
Alfetta GT (tipo 116.10) debuttò ufficialmente nel giugno
1974, in un momento storico sicuramente non favorevole al lancio di
auto sportive: guerra del Kippur, crisi energetica, costo della
benzina alle stelle, introduzione dei limiti di velocità. Insomma,
il clima generale che si respirava in quegli anni penalizzava
fortemente soprattutto quelle Case che, come l'Alfa Romeo, avevano
listini tutti proiettati verso la brillantezza di guida.
|

|
Giorgetto
Giugiaro, nel disegnarla, aveva voluto realizzare una vettura che
potesse essere utilizzata anche dalla famiglia e, per questo motivo,
decise di adottare il portellone al posto di un più tradizionale
cofano per accedere al bagagliaio.
Per
il frontale furono inizialmente elaborate diverse ipotesi, una delle
quali prevedeva palpebre a griglia sopra i fanali (sullo stile
della Montreal): nel taglio definitivo del cofano erano ancora
evidenti, immediatamente sopra i fari, le scanalature derivate
dall'eliminazione delle palpebre laterali.
Il
risultato, comunque, fu notevole: ancora oggi questa bella coupé,
con il suo muso spiovente e il parabrezza e il lunotto molto
inclinati, riesce a trasmettere grinta, velocità, passione, una
caratteristica non rara nei modelli del Biscione che spesso sembrano
non avvertire il tempo che passa.
|

|
Il
pianale era quello dell'Alfetta berlina (con un leggero
accorciamento del passo che scendeva da 2510 a 2400 mm) e pure la
meccanica manteneva le eccellenti caratteristiche di quest'ultima:
anche in questo caso, infatti, si fece ricorso allo schema transaxle
(motore anteriore, cambio e differenziale in blocco al retrotreno;
anche la frizione era posteriore). Anche in questo caso, inoltre, le
sospensioni anteriori erano a quadrilateri e le molle erano a barra
di torsione incernierate sul triangolo inferiore; posteriormente vi
era un assale rigido De Dion con due bracci convergenti non
articolati e un sistema a parallelogramma di Watt per l'ancoraggio
trasversale. L'impianto frenante a doppio circuito era a quattro
dischi, con quelli posteriori sospesi accanto al gruppo
cambio-differenziale. Il propulsore scelto per equipaggiare la
nuova sportiva fu lo stesso generoso bialbero 4 cilindri in linea da
1779 cc che veniva montato sull'Alfetta berlina: 122 cv a 5500
giri/minuto con una coppia massima di 17 Kgm a 4400 giri/minuto.
|

|
Questo
motore era capace di spingere l'Alfetta GT sino alla velocità
massima di 195 Km/h. Gli alfisti dell'epoca rimasero molto perplessi
per la scelta compiuta dal Centro Stile di Arese nel disegnare la
plancia. In particolare, non fu molto gradita la disposizione della
strumentazione, la quale era sostanzialmente suddivisa in due parti.
D'avanti
al pilota, infatti, era alloggiato solo il contagiri, mentre il
tachimetro, il manometro della pressione dell'olio e l'indicatore
del livello del carburante erano stati sistemati al centro della
plancia: se da un lato si trattava di un'impostazione tipicamente
corsaiola, dall'altro venne giudicata dalla maggioranza degli
alfisti poco pratica e anti-estetica.
|

|
In
compenso, il volante e il sedile guida (entrambi regolabili in
altezza) consentivano sempre di trovare con facilità la posizione
di guida ideale. Nel 1974, Quattroruote effettuò la prova su strada
di questa vettura affidandola ai giudizi di Emerson Fittipaldi. Il
pilota rimase favorevolmente impressionato dalla sua doppia
personalità di vettura quasi da famiglia e di coupé sportiva.
Quest'Alfa venne giudicata dal pilota brasiliano neutra o
leggermente sottosterzante nelle curve pianeggianti o in salita, con
un accenno al sovrasterzo in quelle in discesa a causa del
trasferimento di carico verso l'avantreno. Fittipaldi ebbe invece
qualche perplessità nel valutare cambio e sterzo: il primo venne
all'epoca criticato anche da molti clienti per via dell'escursione
troppo lunga della leva e per un livello migliorabile di precisione
e manovrabilità, ma c'è da dire che comunque venne giudicata
in modo molto positivo la scalatura dei rapporti; il secondo avrebbe
meritato di essere più diretto, un problema che secondo lo stesso
Fittipaldi si sarebbe potuto facilmente risolvere montando un
volante di diametro inferiore. Ricordiamo, inoltre, che l'Alfetta GT
fu anche una delle prime Alfa Romeo con scocca a deformabilità
progressiva, progettata secondo criteri di sicurezza, e che per
questo motivo risultò subito conforme alle normative statunitensi
relative ai crash test. Qualche dettaglio stilistico
caratteristico: la mascherina incassata in plastica nera a maglie
rettangolari, priva di qualsiasi ornamento; il tappo del serbatoio
del carburante protetto da uno sportellino; i gruppi ottici
posteriori con cornici cromate. Gamma
dei colori disponibili per la carrozzeria: Azzurro Le Mans, Beige
Cava, Biancospino, Blu Olandese, Faggio, Giallo Piper, Grigio
Indaco, Prugna, Rosso Alfa, Verde Pino, Blu Pervinca, Nero, Beige
Chiaro Metallizzato, Grigio Chiaro Metallizzato, Grigio Medio
Metallizzato. Nel 1975, la
vettura venne rinominata Alfetta GT 1.8 (tipo 116.54): il
propulsore era sempre lo stesso 1779 cc, con una potenza però
ridotta a 118 cv. Si trattava, comunque, di una versione destinata a
restare in listino per poco tempo. Prodotta in 21.947 esemplari fino
al 1976, più uno nel 1979, la serie con motore "1800"
(Alfetta GT e Alfetta GT 1.8) è oggi rara da trovare in buone
condizioni e molto ricercata. La scomparsa dal listino Alfa Romeo
della vecchia Giulia GT, che nell'ultima serie era disponibile con
motorizzazioni 1300, 1600 e 2000, rese possibile un ampliamento
della gamma della nuova coupé. Nel 1976, infatti, l'Alfetta GT
1.8 venne eliminata per lasciare spazio ad una nuova gamma
strutturata in due differenti cilindrate. Arrivarono così l'Alfetta
GT 1.6 e l'Alfetta GTV 2000. La denominazione "Alfetta",
pur rimanendo ufficialmente nei listini della Casa, di fatto
scomparve dalle scritte di identificazione applicate sulle vetture. L'
Alfetta GT 1.6 (tipo 116.04) fu equipaggiata con lo stesso
propulsore che a partire dal 1975 era stato introdotto anche nella
gamma dell'Alfetta berlina: 1570 cc, 109 cv a 5600 giri/minuto, 14.5
Kgm di coppia massima a 4300 giri/minuto.
|

|
Questa
nuova versione non presentava esteticamente grosse differenze
rispetto alla precedente 1800 cc: sopra la targa posteriore c'era
ora la grossa scritta "Alfa Romeo"; i gruppi ottici
posteriori avevano perso le cornici cromate; la mascherina, a
listelli orizzontali, aveva la sezione centrale a filo della
carrozzeria e una serie di feritoie frontali serviva a far
"respirare" meglio il motore. L'Alfetta GT con motore
1600, più rara ma meno ricercata della 1800, riscosse un successo
limitato e venne prodotta fino al 1980 in soli 16.923 esemplari. L' Alfetta GTV 2000 (tipo 116.36)
venne dotata di un propulsore da 1962 cc e 122 cv e beneficiò di
sospensioni ulteriormente irrigidite. La "V" di GTV stava
ovviamente per Veloce.
|
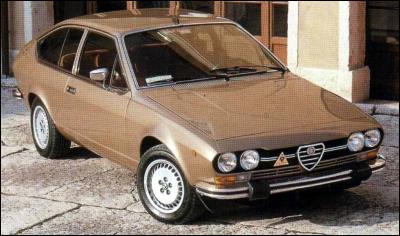
|
Anche
in questo caso, le modifiche estetiche apportate rispetto alla
precedente Alfetta GT 1.8 furono minime: rostri gommati ai paraurti
(non presenti neanche sulla 1600 cc) e placche degli sfoghi d'aria
triangolari sui montanti posteriori con la vistosa scritta forata
"GTV"; come anche sulla 1600 cc, sopra la targa posteriore
era stata inserita la scritta "Alfa Romeo".
Sia
sulla 1600 che sulla 2000, poi, la corona del volante era rivestita
in finta pelle e il comando del lavavetro non era più a pedale ma
collocato sul piantone. Il cruscotto dell'Alfetta GTV 2000 era
impreziosito da un fascione in finto legno.
|

|
Il
tappo del serbatoio del carburante, con serratura, era ora a vista e
la mascherina si distingueva (rispetto alla vecchia 1800 ma anche
alla contemporanea 1600) per i due listelli in metallo lucido. Le
ruote d'acciaio, poi, erano di diverso disegno (fori quadrangolari e
non più tondi) e vennero anche resi disponibili (a richiesta) i
cerchi in lega leggera. I sedili avevano, rispetto alla 1600,
disegno identico, mentre diverso era il disegno dei pannelli porta.
Previsto a richiesta il rivestimento in velluto. L' Alfetta GT 1.6 e
l' Alfetta GTV 2000 restarono in listino sino al 1980. La 2000
cc, però, a partire dal 1978 fu rinominata Alfetta GTV 2000 L
(tipo 116.36A), ma a ben guardare non si trattò di una semplice
ridenominazione. Infatti, su questa nuova versione era ora montato
il motore dell' Alfetta 2000 L: la potenza salì così a 130 cv; gli
ammortizzatori posteriori furono tarati in modo più rigido per
conferire alla vettura un comportamento più neutro in curva;
l'impianto frenante era ora del tutto esente da fading. Inoltre,
adesso veniva anche offerto in optional il condizionatore. In
termini di velocità di punta, comunque, l'Alfetta GTV 2000 L si
collocava agli stessi livelli della prima Alfetta GT da 122 cv: 195
km/h. L'abitacolo poteva essere arricchito con la selleria in pelle:
il lavoro veniva eseguito artigianalmente, esemplare per esemplare,
dalla ditta Lanzoni di Milano, che operava per conto dell'Alfa
Romeo. All'interno, il vano bagagli e la cappelliera vennero
rivestiti in moquette e vennero previsti nuovi rivestimenti in panno
dei sedili e dei pannelli porta. Da ricordare anche che il
parabrezza e il lunotto vennero muniti di guarnizioni e furono
fissati al padiglione in modo tradizionale e non più incollati
(stesso discorso vale, a partire dal 1978, anche per l'Alfetta GT
1.6). Gamma dei colori disponibili per la carrozzeria: Avorio,
Bianco, Blu Olanda, Rosso Alfa, Azzurro Le Mans, Giallo Piper,
Prugna, Verde Pino, Beige Chiaro Metallizzato*, Luce Di Bosco
Metallizzato*, Blu Pervinca Metallizzato*, Grigio Chiaro
Metallizzato* (i colori con asterisco erano disponibili a
richiesta). L'Alfetta GTV 2000 e l'Alfetta GTV 2000 L sono in
assoluto le coupé Alfetta di maggior successo, grazie ad un
eccellente equilibrio tra prestazioni e costi di gestione. La prima
venne prodotta sino al 1978 in 31.267 esemplari; la seconda fino al
1980 in 26.108 esemplari. Relativamente meno rare delle sorelle di
minor cilindrata, restano comunque difficili da trovare in buono
stato e in condizioni originali.
Tutte
le versioni citate sino a questo punto si possono, in linea di
massima, idealmente catalogare come "prima serie".
Ovviamente, non è un raggruppamento completamente corretto, viste
le piccole differenze che comunque esistono tra un modello e
l'altro. Tuttavia, è necessario al fine di distinguere in modo
netto quella che comunemente viene identificata come "seconda
serie", serie caratterizzata da una ristilizzazione estetica
piuttosto consistente e nella quale rientrano le versioni di cui
tratteremo da questo punto in poi.
Alla
fine degli anni Settanta, la coupé di Arese era giunta alla piena
maturità e al massimo successo nelle vendite. Tuttavia, i vertici
aziendali si resero conto che la sua sopravvivenza era legata alla
capacità di competere con una concorrenza che, in questa categoria
di vetture, puntava su cilindrate e quindi su prestazioni sempre più
elevate. Ormai, infatti, la clientela era disposta a
"sopportare" la scomodità delle coupé solo se in cambio
veniva ripagata con accelerazioni brucianti, accompagnate magari dal
sibilo di un sei cilindri. La crisi del petrolio, poi, sembrava
lontana e l'ottimismo per il nuovo decennio che stava per iniziare
rendeva accettabile anche un consumo di carburante elevato. Era
il 1980. La gamma venne rivista nell'estetica e fu questa
l'occasione per introdurre anche una versione equipaggiata con lo
stesso propulsore V6 2.5 che veniva montato sull'ammiraglia Alfa 6:
nel caso dell'Alfetta GT, però, venne abbandonata l'alimentazione a
carburatori (presente sull'Alfa 6) in favore dell'iniezione
elettronica. Fu anche l'occasione per far uscire di produzione
l' Alfetta GT 1.6, essendosi questa rivelata una motorizzazione
troppo poco potente per un modello dal carattere sportivo; c' è però
da dire che la 1600 cc, pur essendone cessata nel 1980 la
produzione, restò in listino ancora per molti mesi allo scopo di
eliminare le scorte. Molte le modifiche estetiche che interessarono
la seconda serie e che furono comuni ad entrambe le due versioni
disponibili: Alfetta GTV 2000 (tipo116.36B) e Alfetta GTV
6 2.5 (tipo 116C). Venne operata una ristilizzazione che,
senza intervenire sui lamierati della carrozzeria, ringiovanì
l'aspetto globale della vettura, grazie a sostanziali aggiornamenti
dei componenti dell'abbigliamento esterno. Frontale, gruppi ottici
posteriori in un unico pezzo e placche degli sfoghi dell'aria in
plastica nera sui montanti posteriori sono gli elementi utili per
distinguere a prima vista una seconda serie da una prima. Di rilievo
erano anche i paraurti in plastica nera e molti altri particolari in
nero (come l'elemento in plastica che raccorda la parte inferiore
della fiancata ai passaruota, i profili dei finestrini e le prese
d'aria sul cofano). Vennero quindi eliminate tutte le cromature; gli
specchietti retrovisori divennero rettangolari e di dimensioni
generose; i cerchi in lega (optional sulla 2000) beneficiarono di un
nuovo disegno. All'interno venne introdotta una plancia dallo stile
completamente rinnovato che abbandonava la vecchia configurazione a
indicatori separati della prima serie in favore di un più
convenzionale elemento unico collocato dietro al volante (anch'esso
ridisegnato) che aveva la corona in legno sulla GTV 2000 e in pelle
sulla GTV 6.
|

|
|
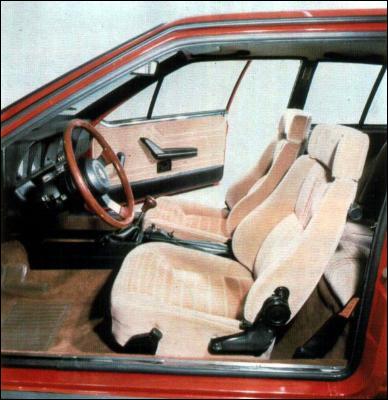
|
|

|
L'
Alfetta GTV 6 2.5, poi, si distingueva dalla 2000cc per la vistosa
protuberanza che caratterizzava il cofano motore allo scopo di
consentire l'alloggiamento del nuovo e più ingombrante propulsore.
La
versione a 6 cilindri, tra l'altro, si distingueva dalla versione
due litri anche per la più generosa gommatura (195/60 HR 15 anziché
185/70 HR 14) e per l'adozione di cerchi in lega leggera di serie.
Anche la meccanica era stata ovviamente adattata a sopportare meglio
le prestazioni superiori, con modifiche alla frizione (bidisco),
alle molle, agli ammortizzatori e ai freni (dischi maggiorati e,
all'avantreno, autoventilati). L' Alfetta GTV 6 2.5 era dunque
equipaggiata con un propulsore 6 cilindri a V di 60° da 2492 cc
capace di erogare una potenza massima di 160 cv a 6000 giri/minuto e
una coppia massima di 21.7 Kgm (212.9 Nm) a 4000 giri/minuto.
|
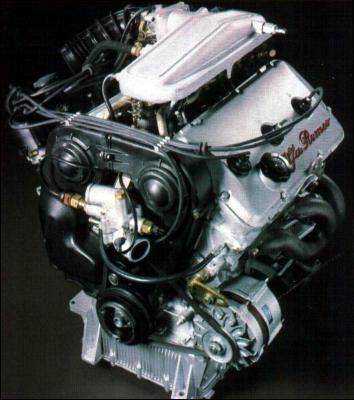
|
Questa
versione a 6 cilindri venne provata, contemporaneamente all'Alfetta
GTV 2000, da Quattroruote nel 1981 e la vettura fu anche affidata
alla valutazione del pilota argentino Carlos Reutemann, all'epoca
pilota in F.1 della Williams. La meccanica della seconda serie dell'
Alfetta GT rimaneva sostanzialmente immutata rispetto alla serie
precedente, ma piccole differenze erano riscontrabili tra le due
versioni (2000 cc e 2500 cc). Per esempio, i dischi anteriori
dell'impianto frenante della 2000 cc erano quelli della Alfetta
berlina 2000 cc, mentre nel caso della GTV 6 2.5 furono installati i
dischi ventilati dell'Alfa 6 con pinze semplici (l'Alfa 6, invece,
montava pinze doppie). Altre differenze erano riscontrabili nella
taratura delle sospensioni e nella geometria dell'avantreno. In ogni
caso, la nuova Alfetta GTV 2000 era, rispetto al modello precedente,
più rigida in quanto dotata di ammortizzatori, molle e barre
antirollio adattate ai nuovi pneumatici (più ribassati rispetto ai
precedenti). L'Alfetta GTV 6 2.5, poi, aveva subìto modifiche
all'avantreno per compensare il maggior peso del nuovo motore a 6
cilindri: l'angolo di incidenza era inferiore (era stato portato da
3,5° a 2°) allo scopo di alleggerire lo sterzo; inoltre, l'angolo
di camber era leggermente negativo (anziché neutro) allo scopo di
contrastare la più accentuata tendenza al sottosterzo prodotta
dall'accresciuto peso anteriore. Per quanto concerne i propulsori,
il bialbero 4 cilindri in linea da 2000cc era praticamente invariato
rispetto ai bialbero adottati sulle versioni precedenti (1962 cc,
potenza massima 130 cv a 5400 giri/minuto, coppia massima 18.3 kgm a
4000 giri/minuto): la coppia era leggermente maggiore rispetto alla
serie precedente, l'erogazione della potenza era più fluida e
l'accelerazione più brillante. Ma fu soprattutto il 6 cilindri a V
di 60° dell'Alfa 6 ad essere ammodernato per l'occasione. Come già
accennato, infatti, l'alimentazione a 6 carburatori utilizzata
sull'ammiraglia Alfa 6 venne sostituita con un'alimentazione a
iniezione elettronica Bosch L-Jetronic: questa trasformazione venne
apportata non con l'intento di ottenere un incremento di potenza
(che infatti risultò invariata, 160 cv a 6000 giri/minuto, mentre
la coppia diminuì passando dai 22.4 Kgm dell'Alfa 6 ai 21.7
dell'Alfetta GTV 6 2.5), ma allo scopo di migliorare la progressione
ai bassi regimi e di ridurre i consumi tramite l'esclusione
dell'alimentazione in fase di rilascio. L'Alfetta GTV 2000, nel
corso della prova su strada di Quattroruote, raggiunse una velocità
di punta di 193,083 Km/h (contro i 190 Km/h raggiunti dalla
precedente Alfetta GTV 2000 L del 1978, dotata di spoiler e
pneumatici diversi) con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,2
secondi. Il chilometro con partenza da fermo venne coperto in 30,8
secondi con una velocità d'uscita di 164,8 km/h. La velocità
massima venne raggiunta in quinta marcia. L'Alfetta GTV 6 2.5
raggiunse invece la velocità massima di 209,960 Km/h con
un'accelerazione da 0 a 100 Km/h in 8,2 secondi; il chilometro
con partenza da fermo venne coperto in 29,4 secondi con una velocità
d'uscita pari a 174,0 Km/h. Anche in questo caso, la velocità di
punta venne raggiunta in quinta marcia.
|

|
Per
quanto attiene al comportamento dinamico, le modifiche ad assetto e
pneumatici avevano consentito un nuovo passo avanti nel
comportamento su strada della vettura: la stabilità venne giudicata
eccellente e in tutte le circostanze la GTV si mostrò a prova
d'errore. Anche la tenuta di strada venne giudicata davvero ottima:
le variazioni d'assetto si manifestavano sempre in modo progressivo
e controllabile. La minore tendenza al rollio, inoltre, aveva
migliorato la maneggevolezza complessiva. In curva, le due Alfetta
provate mostrarono un comportamento leggermente sottosterzante e
tendente a diventare neutro con l'aumentare della velocità. Nella
2500 cc, la maggiore coppia disponibile consentiva di controllare
meglio il comportamento del retrotreno con l'effetto che la vettura
risultava, rispetto alla 2000 cc, più agile da guidare nel misto.
Delle precedenti versioni, invece, era rimasta la tendenza ad avere,
nei curvoni veloci, degli ondeggiamenti che si ripercuotevano sullo
sterzo; era anche rimasta una certa lentezza a iscriversi nelle
curve strette. Sullo sconnesso non furono rilevati problemi
particolari, mentre era sul bagnato che occorreva una certa cautela
nel caso di guida veloce: ciò a causa dell'elevata inerzia che la
vettura manifestava sia nel sottosterzo che nel sovrasterzo. Il
cambio suscitò qualche perplessità. Il comando non disponeva di
sufficiente precisione e l'escursione della leva venne giudicata
eccessiva; inoltre, i giochi della tiranteria producevano e
trasmettevano rumorosità. Questi difetti finivano per offuscare le
qualità del cambio (innesti e sincronizzazione) che erano comunque
apprezzabili. Insomma, si trattava dei difetti tipici di tutte le
Alfa realizzate su meccanica Alfetta (vale a dire, tutte le Alfa a
ponte De Dion). La frizione a comando idraulico era rapida e
abbastanza leggera nella GTV 2000; nella GTV 6 2.5, a causa della
coppia più elevata, era stata adottata una frizione a doppio disco
che presentava una corsa attiva molto breve, ma che doveva essere
premuta a fondo per ottenere il completo disinnesto. Lo sterzo di
queste due GTV rimaneva sempre un comando di impostazione
prettamente sportiva. Non risultava molto pronto, ma restava molto
sensibile anche a velocità elevata e privo di reazioni improvvise.
Nel caso della GTV 6 2.5, la riduzione dell'angolo di incidenza
rendeva praticamente inavvertibile il maggior peso gravante
sull'avantreno: rispetto alla GTV 2000 si notava solamente un
ritorno leggermente meno pronto all'uscita delle curve. Come già
detto, in quell'occasione Quattroruote volle affidare la nuova
Alfetta GTV 6 2.5 ai giudizi di Carlos Alberto Reutemann.
|

|
Le
prime sensazioni del pilota argentino non furono entusiasmanti.
Oggetto delle sue critiche furono lo stile (la GTV 6 venne giudicata
un po' appesantita dai tentativi di modernizzarne la linea), il
volante (considerato dal diametro troppo ampio), il livello
complessivo di finitura (giudicato migliorabile, in rapporto alla
classe della vettura). Progressivamente, però, Reutemann iniziò a
prendere confidenza con l'auto. Dapprima cominciò a saggiare tutta
l'elasticità del propulsore affrontando anche in quarta le ripide
strade del percorso prestabilito; poi iniziò ad affondare in modo
sempre più deciso, con una guida concentrata e precisa. Fu in
questo modo che il pilota giunse a definire "un gioiello"
il V6 che pulsava sotto il cofano. Alcune sue parole: "La
prontezza del motore si sente in accelerazione usando il cambio. La
GTV è sempre disposta a scattare. Ancora migliore l'elasticità: a
800 giri con la quinta si schiaccia e si riprende con molta facilità;
è una marcia che si può mantenere in autostrada e persino in
montagna. Il cambio, invece, non mi sembra all'altezza del resto
della meccanica. I rapporti sono giusti, però i cambi di marcia
sono un po' lenti e imprecisi per una coupé sportiva. Lo sterzo mi
piace soprattutto nelle curve veloci, dove non occorre agire molto
sul volante per mantenere la giusta linea. Nelle curve strette,
invece, non riesco a sentire il comportamento dell'avantreno né a
scegliere le traiettorie con la sufficiente precisione. E' uno
sterzo abbastanza leggero, considerato il fatto che non è
servoassistito; diventa invece faticoso nei percorsi lenti: qui
dovrebbe avere maggiore prontezza. Indubbiamente le Alfa Romeo sono
auto molto sicure e perdonano gli errori di guida anche quando il
pilota sterza in modo non corretto o accelera quando non è il
momento adatto. E' un comportamento sicuro e lodevole in una vettura
che ha a disposizione tanta potenza. Però la GTV 6 manifesta una
certa lentezza nell'inserirsi in curva o meglio, secondo me, ha
troppo sottosterzo nelle curve strette. E' evidentemente un
comportamento scelto dai tecnici Alfa per rendere più sicura la
tenuta per i meno esperti nella guida. Ecco perché nelle curve
strette occorrono sforzi per farla girare nel migliore dei modi.
L'Alfetta GTV mi piace di più nelle curve medio-veloci dove può
far meglio vedere le sue ottime doti di equilibrio tra avantreno e
retrotreno. Anche accelerando di colpo, la potenza non si manifesta
mai in modo troppo brusco; così il sovrasterzo di potenza è molto
graduale e quindi facilmente controllabile." Per quanto
riguarda la gamma dei colori, le tinte disponibili furono
drasticamente ridotte e, in pratica, ne restarono solo tre: Rosso
Alfa, Nero, Grigio Metallizzato. Nel 1981, venne allestita
sulla base meccanica dell'Alfetta GTV 2000 una serie limitata di
circa 600 esemplari denominata Alfetta GTV Grand Prix, per
celebrare la partecipazione dell'Alfa Romeo al Campionato del mondo
di Formula 1.
|

|
Un
solo colore (Rosso Alfa) e una particolare grafica di
identificazione: lungo tutta la fiancata correvano due strisce nere
ed entro quella che univa il parafango anteriore al parafango
posteriore era riportata la scritta rossa "Grand Prix". Gli
interni comprendevano sedili rivestiti in velluto rigato nero e
grigio, moquette rossa sul pavimento, volante con corona in pelle e
targhetta sulla plancia con numero progressivo. La meccanica,
comunque, non presentava alcuna modifica. Nel
1983, ebbe luogo un leggero aggiornamento che, tra l'altro, coincise
con la soppressione ufficiale della denominazione
"Alfetta". Le nuove GTV 2000 (tipo 116.36C) e GTV6
2.5 (tipo 116CA) disponevano ora di vetri azzurrati di serie;
erano poi state aggiunti due profili paracolpi laterali in gomma
nera e la parte inferiore dei fianchi era verniciata in grigio scuro
per raccordarsi otticamente con i paraurti; le cornici dei
finestrini erano ora grigio scuro e i retrovisori in tinta con la
carrozzeria. Erano inoltre presenti il parabrezza con antenna radio
incorporata, lunotto termico di serie e nuovi sedili anteriori con
caratteristiche sportive dotati di appoggiatesta a rete,
rivestimenti in velluto grigio o beige a seconda del colore della
carrozzeria. Anche l'insonorizzazione dell'abitacolo venne
migliorata con una paratia collocata sotto la plancia. Tra gli
equipaggiamenti della GTV6 2.5 c'erano i lavafari, gli alzacristalli
elettrici e i cerchi in lega, mentre la verniciatura metallizzata si
poteva ottenere senza supplemento di prezzo. Si trattava comunque di
piccole modifiche: troppo poco per poter parlare di "terza
serie". Meccanica completamente invariata. Gamma dei colori:
Rosso Alfa, Nero Metallizzato, Grigio Nube Metallizzato, Grigio
Chiaro Metallizzato. In questo modo l'Alfetta GT continuò ad essere
prodotta sino al 1986, ma essa resterà in listino ancora per alcuni
mesi del 1987. Un'ultima scorta di GTV 6 2.5 venne smaltita
realizzando una seconda serie speciale siglata anch'essa "Grand
Prix", destinata esclusivamente al mercato tedesco.
Complessivamente, dal 1974 al 1986, questa bella coupé venne
prodotta in quasi 140.000 esemplari. Molto
apprezzata all'estero fin dall'inizio, l'Alfetta GT e GTV è stata
prodotta in diverse versioni speciali per i mercati esteri. La
versione "America" montò da subito un motore di 2
litri con impianto di iniezione Spica, per rispondere alle normative
antinquinamento vigenti negli USA. La "GTS"
(1600) e la "GTV Strada" (2000), versioni per il
mercato britannico, avevano dotazioni particolarmente ricche, con
accessori e cromature aggiuntive, ma la meccanica era identica a
quella dei modelli di pari cilindrata commercializzati in Italia.
Nel 1977, l'Autodelta, su richiesta del distributore tedesco della
Casa di Arese, realizzò la "GTV 2.6 V8", che
montava il motore della Montreal.
|

|
|
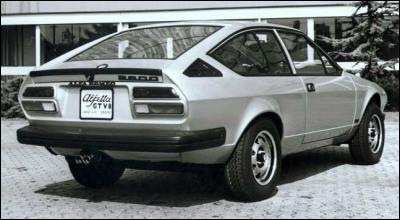
|
|

|
Prodotta
in circa 20 esemplari, questa vettura aveva caratteristiche da vera
supercar: potenza di 200 cv a 6500 giri/min., accelerazione 0-100
Km/h in 7,5 secondi, velocità massima di 230 Km/h. Infine, per
il solo mercato sudafricano, nel biennio 1984-'85 venne allestita la
"GTV 3.0 V6" che, tra l'altro, si distingueva per
una presa "Naca" ricavata sulla "gobba" del
cofano motore.
Il
propulsore aveva una cilindrata portata a 3 litri, alimentazione a
carburatori e potenza di 186 cv. Venne prodotta in circa 200
esemplari per ottenere l'omologazione nel Gruppo 1.
Un
discorso a parte merita la storia di una versione un po' particolare
di Alfetta GT, l' Alfetta GTV 2.0 Turbodelta (tipo 116.36D).
|
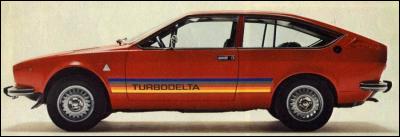
|
Nel
1978, l'Autodelta (il reparto sportivo dell'Alfa Romeo, fondato e
diretto dall'ingegner Carlo Chiti) realizzò in serie limitata
quella che fu la prima vettura (a benzina) di fabbricazione italiana
dotata di turbocompressore. Ne saranno realizzati complessivamente
circa 200 esemplari, più altrettante Alfetta GTV elaborate
"after market" con kit ufficiali. La
Casa contava di raggiungere due obiettivi: uno di carattere
commerciale, ridare slancio alla gamma delle coupé sportive Alfa
Romeo (gamma fortemente penalizzata dalla crisi energetica di alcuni
anni prima); un altro di carattere sportivo, rendere possibile
l'omologazione delle vettura nel Gruppo 4 per poter gareggiare nei
rally (omologazione per la quale era richiesta la soglia minima di
400 esemplari prodotti). Le Alfetta GTV 2000 L (tipo 116.36A), dopo
essere state assemblate, venivano prelevate dalla normale produzione
e inviate all'Autodelta, dove si provvedeva a sostituire il cofano
motore e alcune parti di meccanica con altri componenti già
elaborati. In base a ciò è facile capire come sia oggi impossibile
risalire ai numeri di telaio delle GTV Turbodelta: la numerazione
dei telai delle Turbodelta, infatti, era ricompresa in quella dei
telai delle normali GTV 2000 L. L'idea iniziale era probabilmente
quella di fornire un vero "kit" da montare presso i
concessionari Alfa: questa impostazione di base si poteva anche
intuire dal progetto della vettura, in quanto si seguì una via
abbastanza inconsueta. Ad essere piuttosto inusuale era la presenza
dei carburatori (la GTV Turbodelta era l'unica vettura
sovralimentata di serie europea ad utilizzare i carburatori anziché
l'iniezione) e, inoltre, il fatto che essi erano
"compressi", collegati a valle del gruppo di
sovralimentazione. Per garantire il loro regolare funzionamento,
essi dovettero essere pressurizzati: tutte le aperture che
normalmente erano in comunicazione con l'esterno furono collegate in
pressione con il condotto di aspirazione. Risultava quindi evidente
l'intenzione dei tecnici Autodelta di lasciare per quanto possibile
inalterata la meccanica del propulsore: diverse parti, come per
esempio la scatola del filtro dell'aria, erano direttamente derivate
da quelle del motore aspirato. Il turbo si trovava alla sinistra del
motore, all'estremità del corto collettore di scarico, e
l'aria compressa veniva inviata (attraverso il tubo che passava
sopra la testa) al cassoncino applicato ai carburatori.
|

|
La
pressione massima di sovralimentazione era di 0,7 bar ed era
ovviamente regolata da una valvola waste-gate sul condotto di
scarico. Il rapporto di compressione passava da 9 del motore
aspirato a 7,1. Il turbocompressore (fabbricato dalla KKK) fu
completamente modificato per adeguare forma e materiale delle
turbine alle necessità del motore a benzina, che lavora ad
altissime temperature (intorno ai 1000°). Come già detto sopra,
questo turbocompressore era alloggiato a monte dei due carburatori
che, oltre ad essere stati pressurizzati, erano stati dotati
anche di nuove guarnizioni, più adatte a sopportare la
sovralimentazione e la pressione conseguente. Altre parti
modificate nella meccanica dall'Autodelta erano i pistoni, le canne
cilindri, le guarnizioni della testa metalliche, il radiatore acqua
maggiorato, la pompa benzina elettrica, la frizione rinforzata, gli
alberi a camme, l'impianto di scarico, gli ammortizzatori con
diversa taratura. Il risultato fu quello di riuscire ad ottenere
rispetto al motore di partenza (quello da 130 cv della GTV 2000 L)
un incremento di 20 cv, arrivandosi così a 150 cv; ovviamente, si
ebbe anche un incremento del valore di coppia motrice, la quale passò
da 18 a 23,5 Kgm.
|

|
La
velocità massima dichiarata dalla Casa era di 205 Km/h. Ecco qui di
seguito le curve di potenza e di coppia della GTV Turbodelta, a
confronto con quelle della GTV 2000 aspirata.
Esteticamente,
la GTV Turbodelta si distingueva dalla altre versioni di Alfetta GTV
esclusivamente per le striscie multicolori (non rare a quell'epoca)
applicate sulle parti basse delle fiancate e per il cofano nero.
Nell'abitacolo restava tutto invariato, con la sola aggiunta del
manometro della pressione del turbo.
Una
interessante curiosità. Alcune GTV Turbodelta presentavano una
modifica a quella porzione di griglia che, nel frontale, ospitava il
tipico scudo Alfa Romeo: si trattava di una variazione apportata
dagli stessi tecnici Autodelta che "aprivano" la
mascherina per migliorare l'afflusso di aria fresca.
|

|
Quattroruote
provò su strada l'Alfetta GTV Turbodelta nel 1979. La rivista iniziò
subito col constatare come, ad eccezione del cofano nero, il corpo
vettura della Turbodelta fosse sostanzialmente invariato rispetto a
quello della versione aspirata da cui essa derivava. E venne notato
come anche all'interno ci fosse stata solo l'aggiunta del manometro
della pressione di sovralimentazione. Era stato un peccato, si
sosteneva, perché l'Autodelta avrebbe potuto osare di più. Oggi,
però, a più di vent'anni di distanza, possiamo dire che la scelta
di non "appesantire" troppo lo stile già molto
caratteristico della GTV non fu forse un errore così grande. In
quella prova su strada il funzionamento del propulsore venne
giudicato semplicemente entusiasmante.
|

|
Privilegiando
la coppia motrice (la quale, rispetto alla versione aspirata era
aumentata del 30%, mentre l'incremento di potenza era del 15%), si
era riusciti ad ottenere un motore che ai bassi regimi era capace di
una progressione straordinaria e che consentiva di marciare anche
sotto i 1000 giri in quinta e di riprendere con facilità; era però
a partire dai 3000 giri che il turbo mostrava le sue migliori
caratteristiche. Tutto ciò significava che anche in città non era
affatto difficoltoso mantenere la quinta. Nella medesima prova su
strada, la Turbodelta venne messa a confronto con altre due vetture
2000 cc sovralimentate presenti sul mercato: la Porsche
"924" (170 cv) e la Saab "900 Turbo" (145 cv). Ebbene, il confronto si rivelò in
termini di elasticità favorevole alla vettura del Biscione. Nella
ripresa da 30 Km/h, l'Alfa era più veloce delle due concorrenti,
infliggendo 1,5 secondi alla Saab e addirittura 7 secondi alla
Porsche. Rispetto alla GTV aspirata, poi, la versione sovralimentata
guadagnava 2 secondi. Anche nelle prestazioni tipicamente sportive,
la Turbodelta si comportò molto bene: venne raggiunta la velocità
massima di 203,62 Km/h (in quinta marcia) e l'accelerazione da 0 a
100 Km/h fu effettuata in 8 secondi netti; il chilometro con
partenza da fermo venne percorso in 29,12 secondi con una velocità
d'uscita pari a 180,0 Km/h: solo 2 secondi in più della 924 che
disponeva però di 20 cv in più. Inutile dire come la Saab 900 uscì
dal confronto perdente su tutti i fronti. I risultati ottenuti dalle
tre vetture dipendevano sia dalle scelte tecniche che dal tipo di
rapporti, elementi sempre determinanti per quanto riguarda velocità,
accelerazione, consumo. La Porsche, coi suoi 170 cv, era la più
potente delle tre, ma si giovava di rapporti molto lunghi: in tal
modo, essa risultava veloce (227,84 Km/h) e consumava relativamente
poco in autostrada; il rovescio della medaglia, però, consisteva
nel fatto che la vettura, con una quinta che consentiva la velocità
di 39,7 Km/h a 1000 giri, era fortemente penalizzata nella ripresa:
era infatti la più lenta delle tre vetture confrontate. La Saab
pagava caro invece il disporre di un cambio a 4 marce, con rapporti
corti: la "900", quindi, pur essendo molto elastica,
consumava troppo in autostrada senza neanche riuscire a raggiungere
velocità adeguate alla potenza a disposizione (145 cv): la velocità
di punta era infatti di 187,21 Km/h. L'Alfa, per la sua creatura,
aveva preferito curare molto l'elasticità. Benché la sua coppia
massima fosse inferiore a quella della Porsche (23,5 Kgm a 3500
giri/minuto contro 25 Kgm a 3500 giri/minuto), i rapporti invariati
rispetto a quelli della versione aspirata le consentivano una
eccellente ripresa (era la più rapida delle tre vetture
confrontate), compromettendola però sia nella velocità massima sia
nel consumo in autostrada. Invece, su percorsi misti i consumi erano
abbastanza vicini tra loro: in tutte e tre le vetture ci si aggirava
intorno ai 15 litri per 100 Km.
|

|
Il
comportamento in curva, già d'altissimo livello sull'Alfetta,
risultò ulteriormente migliorato su questa particolare Alfetta GTV:
l'inserimento venne giudicato eccellente, le derive erano contenute,
il passaggio (accelerando in curva) dal sottosterzo al sovrasterzo
era graduale e tale da non mettere mai in difficoltà il pilota con
improvvise "scodate". Anche il confort venne
giudicato di buon livello sia per le caratteristiche delle
sospensioni sia perché il rumore del turbo era poco avvertibile:
solo sul rilascio si avvertiva il caratteristico sibilo della
valvola di sovrapressione. Forse si sarebbe potuto fare di più
per quanto riguarda il rollio in curva, ricorrendo ad un assetto
dalla taratura più rigida. Per quanto riguarda il cambio, rimaneva
la classica manovrabilità difficile dell'Alfetta, soprattutto
nell'innesto della prima marcia. Inoltre, con l'aumento della
coppia, i rapporti diventavano un po' corti ed era molto facile
andare in fuorigiri. In questo senso, una quinta marcia un po' più
lunga avrebbe offerto maggiori vantaggi, anche in termini di
consumi. Sterzo e freni erano invariati rispetto alle altre GTV
all'epoca in produzione. Sotto questo aspetto, Quattroruote si
domandava come mai non fossero stati adottati i dischi autoventilati
dell'Alfa 6: già sappiamo come sulla GTV 6 2.5 che sarebbe nata da
lì a poco questa scelta venne saggiamente compiuta. L'Alfetta GTV
2.0 Turbodelta, che al momento del lancio costava 15.505.000 lire (4
milioni e 700 mila lire in più della GTV 2.0 con motore aspirato)
fu disponibile dal 1979 al 1981.
Come
già detto, oltre che per motivi commerciali, la GTV Turbodelta
venne realizzata anche allo scopo di rendere possibile
l'omologazione della vettura nel Gruppo 4 per poter gareggiare nei
rally (omologazione per la quale era richiesta la soglia minima di
400 esemplari prodotti). E proprio alla versione di GTV Turbodelta
impiegata nelle competizioni vogliamo dedicare uno spazio.
|

|
Già
nel 1978, l'Alfetta GTV Gruppo 2 aveva vinto con Pregliasco il
titolo Turismo Gruppo 2 nel campionato italiano, sconfiggendo le
Opel allora considerate imbattibili. Il debutto sportivo dell' Alfetta
GTV Turbodelta Gruppo 4 era stato previsto per l’autunno del
1979 al Giro d'Italia, dove Pregliasco avrebbe dovuto fare coppia
con Niki Lauda (all’epoca pilota della Brabham-Alfa di F.1). La
vettura da competizione, però, non era ancora pronta (a differenza
della versione stradale già commercializzata da diversi mesi) e così
a correre fu sempre la vecchia GTV Gruppo 2 (senza Niki Lauda).
L'intervallo di tempo precedente all’inizio della stagione
rallistica 1980 fu impiegato per continuare il lavoro di sviluppo,
lavoro affidato ai collaudatori Autodelta Teodoro Zeccoli e Giorgio
Francia (affiancati dal pilota ufficiale Mauro Pregliasco). Rispetto
alla versione stradale, la scocca venne completamente alleggerita:
si utilizzarono lamierati più sottili e si sia adottarono porte,
parafanghi (allargati) e cofani in vetroresina; si intervenne anche
sui vetri (laterali e posteriore) che ora erano in lexan; lo scudo
Alfa Romeo del frontale venne realizzato in plastica e il cruscotto
fu ricostruito in fibra di vetro. Tutto ciò nel tentativo di
raggiungere il minimo previsto dalla fiche di omologazione: 900 kg.
I tecnici Autodelta arrivarono a 950.
|

|
Le
sospensioni riprendevano l’impostazione di serie: all'avantreno vi
erano i doppi triangoli (però con bracci in alluminio) e le barre
di torsione; al retrotreno trovavamo il ponte De Dion (con diversa
altezza del parallelogramma di Watt per abbassare la vettura). Tutte
le sospensioni erano montate su snodi metallici. Le ruote erano
8Jx13" per lo sterrato e 8Jx15" per l’asfalto e
adottavano i primissimi cerchi scomponibili Speedline già provati
sull’Alfetta GTV Gruppo 2. Sull'asfalto venivano montate gomme
Pirelli 235/45 VR all'avantreno e 295/35 VR al retroreno; sullo
sterrato, invece, venivano utilizzate le 185/70 d'avanti e le 205/70
di dietro.
|

|
I
freni erano Lokeed a disco autoventilati anteriori e posteriori;
ovviamente, anche in questo caso gli schemi meccanici erano quelli
tipici delle Alfa a ponte De Dion coi dischi posteriori sospesi
all'uscita del differenziale. Il cambio utilizzava la scatola
dell’Alfetta 2000 e gli ingranaggi della 2500 con rapporti
ravvicinati. Due le coppie coniche utilizzate: quella di serie e una
più corta. Ovviamente si trattava di un cambio in blocco con il
differenziale: 5 rapporti + RM con ingranaggi ravvicinati
sincronizzati. Veniva anche utilizzato un differenziale ZF
autobloccante a lamelle, tarato al 50-75% con molle Belville di
precarico. L’Autodelta provò anche vari tipi di cambi a innesti
frontali, i quali però non vennero mai utilizzati in gara. Il
motore era derivato da quello dell'Alfetta GTV 2000 Turbodelta
stradale da 150 cv che, a sua volta derivava dal propulsore
dell'Alfetta GTV 2000 L da 130 cv: la pressione di sovralimentazione
era stata però portata a 1-1.5 bar. L'esordio
avvenne agli inizi di febbraio 1980, al Rally della Costa Brava, in
Spagna. La GTV Turbodelta Gruppo 4, con i suoi 270 CV (ma nel corso
del tempo si arriverà a toccare anche picchi di 340 cv) erogati a
6000 giri/minuto e la sua coppia massima di 36 Kgm a 5000
giri/minuto, complessivamente non era male: già al debutto, la
Turbodelta Gruppo 4 era vicinissima a vetture vincenti come Fiat 131
Abarth, Lancia Stratos e Porsche 911; ciò era dovuto anche
all’ottima distribuzione dei pesi, garantita dal motore anteriore
e dal cambio posizionato posteriormente, che forniva alla Turbodelta
un comportamento molto equilibrato. Era però l'affidabilità a
creare parecchi problemi, soprattutto per quanto riguardava lo
scambiatore di calore che non funzionava a dovere: proprio a causa
di questo inconveniente la potenza disponibile a inizio gara andava
poi progressivamente degradando a causa delle elevate temperature di
esercizio raggiunte dal motore. Nonostante ciò, in Spagna,
Pregliasco riuscì comunque a concludere la gara in terza posizione;
l’altro pilota ufficiale Alfa, Maurizio Verini, fu bloccato da
un’avaria alla valvola wastegate. Altri problemi per questa Alfa
da rally derivavano dall’impianto di alimentazione: il turbo,
infatti, esattamente come nella versione stradale, non era abbinato
all’iniezione bensì ai carburatori che lavoravano in pressione.
Quindi i raccordi in gomma telata (allora non esistevano quelli per
l’alta pressione) non garantivano sempre una perfetta tenuta,
causando spesso trafilamenti di benzina. Lo stesso turbo diede dei
problemi: dopo aver provato a lungo un prototipo della Spica, l’Autodelta
scelse anche per la versione da competizione un turbocompressore KKK.
Questo era caratterizzato da un notevole ritardo di risposta (il
famigerato "turbo-lag") per contrastare il quale, al via
delle prove speciali, il pilota era costretto a inserire la prima
marcia tenendo la frizione in presa e contemporaneamente doveva
tenere ferma la macchina col freno: in questo modo la pressione di
sovralimentazione saliva. In curva, invece, si era costretti a
frenare con il piede sinistro, mentre contemporaneamente si
accelerava con il destro per non fare calare i giri della turbina e
non perdere così potenza. A metà della stagione rallistica 1980 la
Turbodelta venne aggiornata nella meccanica. Fu installato uno
spettacolare cofano motore tutto pieno di gobbe e feritoie: il
rigonfiamento principale serviva ad ospitare la presa d'aria per lo
scambiatore di calore; le prese e le feritoie avevano ovviamente lo
scopo di far entrare aria fresca e di far uscire aria calda.
|

|
|

|
|

|
|

|
Al
Rally Targa Florio l’Alfa sfiorò la vittoria: Pregliasco, in
lotta serratissima con il leader della gara (Vudafieri su 131 Abarth),
uscì di strada proprio a causa della precedente uscita del suo
avversario la cui 131 ostruiva il passaggio. Verini si classificò
terzo. In Sardegna, però, le due vetture in gara ritornarono ad
avere problemi di affidabilità: Pregliasco fu costretto al ritiro;
Verini, nonostante problemi di raffreddamento, riuscì a
classificarsi comunque al quarto posto e a passare così in testa al
campionato italiano. All'Elba, inizialmente, si manifestarono
problemi all’impianto di aspirazione. Successivamente Pregliasco
riuscì a rimontare sino alla terza posizione, ma durante una prova
speciale la sua macchina prese fuoco. Verini avrebbe potuto
concludere secondo (e sarebbe così rimasto in testa al campionato
italiano) se non si fosse rotto un semiasse. Problemi su problemi,
dunque. Tuttavia, un po' per il suo aspetto e un po' per il turbo,
la GTV Turbodelta era diventata la beniamina del pubblico: il
suo arrivo in prova speciale era preceduto dal tipico (e
affascinante) fischio che si manifestava in fase di rilascio e il
pubblico ne restava catturato.
|

|
Il
Rally "Quattro Regioni" fu un calvario per la vettura che
concluse in settima posizione. AI "Sabbie d'Oro", in
Bulgaria, le cose non cambiarono: la Turbodelta di Pregliasco fu
costretta al ritiro per un sassolino entrato nella turbina e quella
di Verini venne bloccata dalla rottura di un condotto della
benzina. Ma proprio quando alla squadra sembrò che la propria
vettura avesse toccato il fondo, arrivò il primo e unico successo
sportivo. Anche in Romania, al Rally del Danubio, il motore della
vettura di Pregliasco sembrava deciso a costringere la Turbodelta ad
un altro ritiro. Sembra una barzelletta, ma è tutto vero: per puro
caso i meccanici Autodelta sbagliarono strada e, grazie a questo
errore, incrociarono Pregliasco in difficoltà proprio dove loro non
avrebbero dovuto essere. Ripararono il guasto e la Turbodelta vinse.
A Ypres, in Belgio, riprese la tendenza negativa: ci fu un doppio
ritiro, con Pregliasco subito in testa ma costretto allo stop per
problemi ai freni. In Polonia, il peso della Turbodelta venne
ridotto di 100 chili e venne anche installato un nuovo scambiatore
di calore, ma proprio quando la vettura era davanti alla Porsche del
pilota spagnolo Zanini sopraggiunse un altro problema tecnico: la
rottura di un tubo dell'olio fermò Pregliasco quando era in seconda
posizione. Al rally di Madeira, fu Verini a fare una grande gara:
era in testa davanti alla 131 Abarth di Vudafieri quando un’avaria
ai freni lo costrinse dietro alla Fiat. Alla fine si classificò
secondo. Al "Liburna", Pregliasco era dapprima al comando.
Poi scese in seconda posizione, a un soffio dal fortissimo
"Tony". Alla fine venne fermato dalla rottura di un
semiasse. Fu in questa poco incoraggiante situazione che si arrivò
al Rally di Sanremo, valido per il campionato mondiale. La
Turbodelta vinse delle prove speciali davanti a tanti piloti
fortissimi e al fuoriclasse tedesco Walter Rhorl, ma anche qui le
due Turbodelta si ritirarono: quella di Verini s’incendiò, quella
di Pregliasco ebbe un’avaria alla pompa della benzina quando
occupava la quarta posizione. Dopo il "Sanremo" sembrava
che la squadra rally dell’Autodelta dovesse rafforzarsi per il
1981. Si parlava anche dell’arrivo di Giorgio Pianta, l’allora
direttore sportivo dell’Abarth. Invece, dopo il terzo posto di
Verini e il quinto di Pregliasco a San Marino, le Turbodelta
conclusero la loro carriera con un doppio ritiro al Rally di Monza:
Pregliasco, in testa, ruppe il motore e Verini finì fuori strada
quando è primo. Poi l’Alfa Romeo, già impegnata a fondo in F.1,
diede l'annuncio del proprio ritiro dal rally: la GTV Turbodelta
Gruppo 4 concluse così la sua breve e poco fortunata carriera.
|
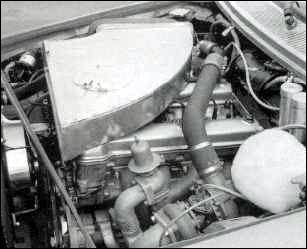
|
|

|
|